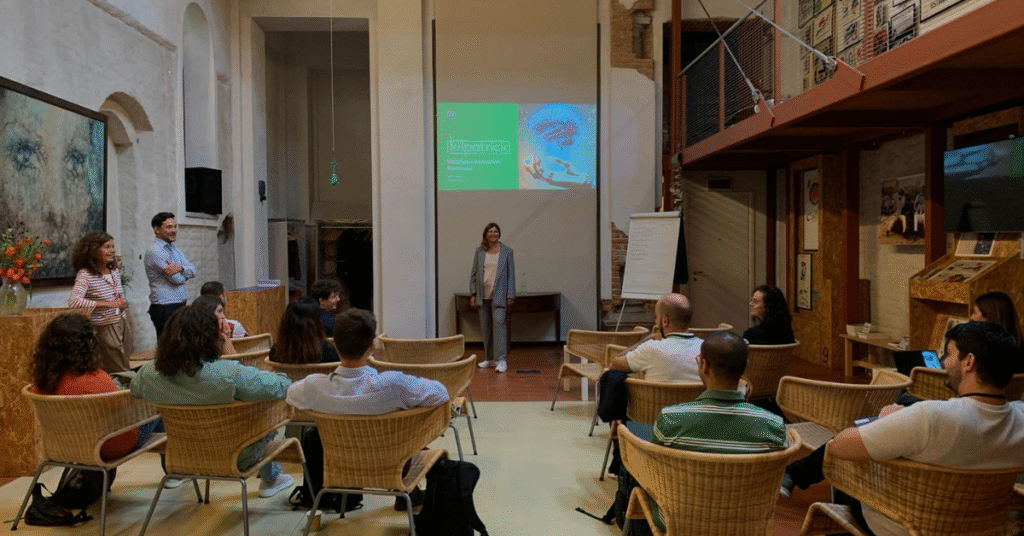Dal 9 al 13 settembre 2025 si è svolto a Milano il Pathfinder Innovation Bootcamp, promosso da Miticoro Foundation, una fondazione no-profit dedicata ai Rising Leaders che operano in aziende e istituzioni e che si trovano ad affrontare sfide di crescente complessità. La Fondazione agisce per sviluppare un’identità europea nella nostra società e promuove lo stile della Humanistic Leadership, con l’obiettivo di creare una comunità di impatto attraverso processi collaborativi.
Il Bootcamp Pathfinder è stato concepito per accompagnare dottorandi e postdoc nella transizione dal mondo accademico a quello professionale, offrendo strumenti pratici, momenti di confronto e opportunità di networking con esperti provenienti da diverse aree del business. Tra i protagonisti di questa edizione, il 10 settembre ha preso parte come relatrice Claudia Paoletti, Managing Partner di Kilpatrick Executive, che ha condiviso la propria esperienza come esperta di headhunting, talent strategy e career development.
Un contesto BANI e nuove esigenze di mercato
Il punto di partenza dell’intervento è stato il contesto in cui ci troviamo a operare: un mondo definito BANI (Brittle, Anxious, Nonlinear, Incomprehensible). La fragilità dei sistemi globali, l’ansia che caratterizza molte generazioni, la non-linearità dei cambiamenti e l’incomprensibilità delle trasformazioni tecnologiche ed economiche rendono evidente che le competenze del passato non bastano più.
In questo scenario, le aziende non possono più attrarre talenti con le stesse leve di una volta. Le nuove generazioni di professionisti chiedono molto più di uno stipendio competitivo: work-life balance, mission e valori aziendali chiari, opportunità di crescita continua, possibilità di innovare, impatto sociale e stabilità sono diventati elementi determinanti nella scelta di un percorso di carriera
Questo spostamento di prospettiva obbliga sia le imprese sia i candidati ad abbracciare il cambiamento: da un lato, le aziende devono ripensare il loro modello di attrazione e retention; dall’altro, i professionisti – inclusi i ricercatori che scelgono di uscire dall’accademia – devono attrezzarsi con nuove competenze e una mentalità più agile.
Come ricordato durante l’intervento, la domanda centrale è se i lavori di oggi esisteranno ancora domani. Secondo stime di McKinsey, entro il 2030 l’8-9% della domanda occupazionale riguarderà ruoli che oggi ancora non esistono
In questo senso, reskilling e upskilling non sono più opzioni ma necessità. Competenze come pensiero critico, intelligenza culturale, empatia strutturata, capacità di collaborazione multidisciplinare e attitudine alla trasformazione digitale diventano imprescindibili per costruire carriere solide in un mercato sempre più fluido.
PhD e imprese: punti di forza e criticità
All’interno di questo quadro, i ricercatori con un PhD rappresentano un patrimonio di talento unico, con caratteristiche distintive che possono diventare un grande valore per le imprese. Le aziende riconoscono nei PhD competenze specialistiche solide, rigore metodologico, capacità di affrontare problemi complessi, resilienza e autonomia nella ricerca. Sono qualità preziose in un contesto di crescente complessità, dove la capacità di analizzare criticamente e proporre soluzioni innovative è sempre più richiesta.
Tuttavia, emergono anche delle criticità che non possono essere ignorate. Spesso i ricercatori arrivano sul mercato del lavoro relativamente tardi, con aspettative elevate, ma con limitata esperienza diretta con clienti e stakeholder, e un linguaggio tecnico che rischia di essere distante dalle logiche aziendali. Questa distanza può tradursi in un vero e proprio rischio di “cultural rejection”, dove le imprese non riescono a integrare appieno il valore portato da questi talenti.
Per superare queste barriere, è fondamentale valorizzare la carriera accademica in chiave più ampia, trasformando le competenze maturate nella ricerca in leve immediatamente riconoscibili dal mondo corporate. Ciò significa:
- tradurre le proprie capacità in un linguaggio comprensibile alle aziende, mettendo in evidenza non solo il “cosa” si è studiato, ma soprattutto il “come” queste competenze possano generare impatto;
- sviluppare competenze trasversali come storytelling, public speaking e networking, che consentano di costruire un dialogo efficace con i decision-maker;
- saper raccontare la propria storia professionale in modo autentico e strategico, costruendo un personal branding coerente online e offline, capace di riflettere valori, professionalità e coerenza di percorso.
In questo senso, il passaggio dall’accademia al mondo del lavoro non è solo un cambio di contesto, ma un vero processo di sviluppo dei talenti. È un percorso che richiede di aggiornare le proprie competenze (digital skills, lingue straniere, attitudine al cambiamento), ma anche di potenziare le cosiddette human skills – empatia, creatività, capacità di collaborare – che restano il vero fattore differenziante in un mercato del lavoro sempre più influenzato dalla tecnologia.
Il messaggio centrale è chiaro: i titoli accademici non definiscono da soli il valore di un professionista; ciò che conta davvero sono le competenze, l’impatto che si riesce a generare e la capacità di contribuire all’evoluzione delle persone e dei sistemi. Per questo, oggi più che mai, i ricercatori sono chiamati a diventare protagonisti attivi del proprio percorso, imparando a trasformare le loro conoscenze in un linguaggio e in un valore comprensibile per il mondo aziendale.
Il fattore generazionale: nuove domande, nuovi paradigmi
Un altro aspetto cruciale riguarda il tema generazionale, oggi più che mai al centro del dibattito sul futuro del lavoro. Le nuove generazioni entrano nel mercato con aspettative profondamente diverse rispetto a quelle dei loro predecessori: non cercano soltanto stabilità economica, ma desiderano crescere in contesti che riflettano i loro valori personali, che offrano opportunità di sviluppo continuo, innovazione e un impatto tangibile sulla società. Questa trasformazione non è marginale: sta ridisegnando i modelli organizzativi, imponendo alle aziende di ripensare radicalmente le proprie strategie di employer branding, talent management e leadership.
Parlare di generazioni significa parlare di valori, linguaggi e priorità differenti, che inevitabilmente incidono sul modo in cui il lavoro viene vissuto e percepito. È un tema “scottante”, che tocca trasversalmente tutti i settori e che condiziona il rapporto tra imprese e persone. Proprio per questo, oggi più che mai, è importante aprire spazi di ascolto e confronto, dove non solo i leader, ma anche i professionisti stessi possano condividere le proprie esperienze e aspettative.
In linea con questa necessità, Kilpatrick Executive sta portando avanti un survey internazionale dedicato a comprendere come le diverse generazioni percepiscono il lavoro e le organizzazioni, e come queste aspettative varino a seconda dei contesti geografici e culturali. È un’iniziativa che si collega perfettamente al tema affrontato durante il Bootcamp e che rappresenta un ulteriore tassello per leggere le trasformazioni in atto.
Se anche tu vuoi condividere la tua opinione o approfondire questi aspetti, puoi partecipare al nostro sondaggio a questo link: Partecipa al survey.
Oltre la comfort zone: trasformare competenze in opportunità
Claudia ha evidenziato l’importanza di uscire dalla comfort zone: rivalutare le proprie motivazioni, sviluppare consapevolezza del proprio percorso e trasformare le competenze maturate nell’accademia in opportunità professionali concrete
Alcuni consigli pratici condivisi durante il suo intervento hanno riguardato:
- Comunicazione e personal branding: saper raccontare la propria storia in modo autentico e coerente, calibrandola sugli interlocutori (CEO, HR, Operations, ecc.).
- Networking consapevole: identificare i decisori, i facilitatori e gli informatori che possono aprire l’accesso al mondo corporate.
- Reskilling continuo: investire in digital skills, lingue straniere e soft skills per ampliare il proprio raggio d’azione.
- Mindset orientato al cambiamento: interpretare la trasformazione non come una minaccia, ma come un’opportunità per innovare e crescere.
Questi elementi, uniti a una maggiore attenzione al personal branding online e offline, consentono ai ricercatori di presentarsi al mercato con credibilità, visione e autenticità.
Conclusioni: il lavoro come progetto in continua evoluzione
Come ha ricordato Claudia Paoletti:
“Non è l’Intelligenza Artificiale a sostituire le persone, ma le persone che sapranno abbracciare l’AI sostituiranno quelle che non lo faranno. Non si può guidare il business di domani con il talento di ieri.”
Questa riflessione ci porta a un punto centrale: il futuro del lavoro non è un destino già scritto, ma un progetto in continua costruzione, che richiede a tutti – aziende, istituzioni, università e professionisti – di assumere un ruolo attivo e consapevole.
Il Pathfinder Innovation Bootcamp ha dimostrato come sia cruciale creare luoghi di confronto dove il sapere accademico possa incontrare le logiche aziendali. Iniziative di questo tipo non si limitano a trasferire competenze, ma stimolano una trasformazione più profonda:
- aiutano i ricercatori a riconoscere il valore del proprio percorso e a trasformarlo in un linguaggio comprensibile e utile per le imprese;
- incoraggiano le aziende a ripensare i propri modelli di attrazione e sviluppo dei talenti, aprendosi a nuove prospettive e a professionalità non convenzionali;
- favoriscono la nascita di una comunità intergenerazionale, capace di leggere i cambiamenti sociali e tecnologici e di trasformarli in opportunità.
In un’epoca segnata da incertezza e rapidi mutamenti, la capacità di adattarsi, di apprendere e di innovare non è più una competenza accessoria, ma il vero fattore competitivo. Creare ponti tra mondi diversi – ricerca e impresa, accademia e mercato – diventa allora una condizione imprescindibile per preparare i leader di domani.
Il futuro del lavoro appartiene a chi saprà interpretarlo con curiosità, responsabilità e visione. E proprio eventi come il Pathfinder Innovation Bootcamp ci ricordano che il cambiamento non va temuto, ma coltivato come terreno fertile per costruire un futuro più sostenibile, inclusivo e capace di generare valore per tutti.